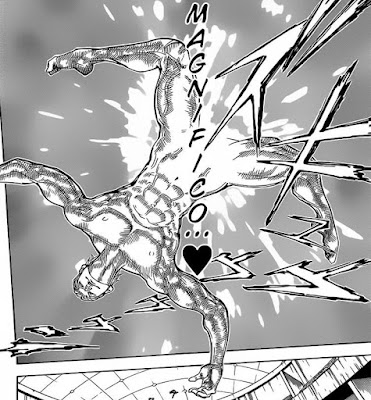Lo so che volevate tutti Regazzoni. E
invece no, sono pigro e mi pesa leggerlo, quindi vi rifilo una recensione
positiva.
L’ultima recensione che ho pubblicato
nella sezione libri è quella di American
gods, cui ho dato otto Cthulhu, che
più o meno significa “certe cose mi sono piaciute tanto, certe altre
discretamente, qualcuna no, siamo a un livello sopra la media ma non
eccellente”. Quello è stato il mio primo e ultimo approccio con Gaiman (con
l’esclusione del fantastico Buona apocalisse
a tutti, ma lì c’è anche l’intervento di Terry Pratchett). Poi proprio
qualche giorno fa, un po’ per caso, un po’ perché avevo bisogno di qualcosa di
breve per riempire il tempo perché avevo appena finito Lord of emperors di Guy Gavriel Kay e nel giro di pochissimo
sarebbero arrivati i libri che avevo chiesto per Natale, ho letto L’oceano in fondo al sentiero. È stato
proprio una cosa casuale, non dico che ho messo vari titoli di libri su un
bersaglio e poi ho lanciato una freccetta a occhi chiusi, ma quasi. E quello
che doveva essere soltanto un riempitivo tra un bel libro e l’altro è diventato
in effetti il miglior libro che ho letto quest’anno. E sì, questo è l’anno in
cui ho letto anche Pan e Sailing to Sarantium. Eppure L’oceano in fondo al sentiero dà il
bianco a tutti quanti.
______________________________________________
Autore:
Neil Gaiman
Anno:
2013
Editore:
Mondadori
Pagine:
191
TRAMA
La trama è
semplicissima. Il protagonista e narratore della storia, di cui non conosciamo
il nome e che perciò chiameremo con il primo che mi viene in mente, Neil
(scelta assolutamente casuale), ritorna presso la casa dove abitava quando era
piccolo. Lì ritrova la fattoria degli Hempstock, dove abitava Lettie, una
bambina con cui aveva fatto amicizia quando lui aveva sette anni e lei undici,
e che poco dopo si era trasferita in Australia. Neil giunge allo stagno della
fattoria, quello che Lettie definiva il suo oceano. E i ricordi di quella
lontana estate di tanti anni prima tornano a galla.
Viviamo
perciò insieme a Neil l’avventura che ha vissuto quando aveva sette anni e
viveva nel Sussex con la sua famiglia. Quando era un ragazzino timido, chiuso e
introverso, che passava più tempo sui libri che a fare sport. Quando suo padre
affitta una camera a un cercatore di opali e questi per sbaglio investe e
uccide Fluffy, il gattino di Neil. Quando anche il cercatore di opali viene
trovato poco tempo dopo morto e delle monete cominciano a comparire misteriosamente
in giro nei posti più impensabili. Quando Neil conosce Lettie Hempstock e lei
gli mostra uno stagno che in realtà dovrebbe essere un oceano ma sembra proprio
uno stagno, e una creatura misteriosa decide di voler fare felici le persone.
 |
| Neil Gaiman e Terry Pratchett olio su tela. |
LA MIA OPINIONE
L’oceano
in fondo al sentiero è
la dimostrazione che per scrivere un romanzo eccellente non serve una trama
complicata, né un cast di personaggi più lungo dell’elenco telefonico, né una
lunghezza minima di almeno 500 pagine. Gaiman non fa nessuna di queste cose
eppure riesce a scrivere un romanzo straordinario.
L’oceano
in fondo al sentiero non
è un romanzo per bambini, eppure ha le movenze e l’atmosfera della favola. Si è
immersi in un mondo delicato e toccante, visto attraverso gli occhi del
protagonista, che sta simpatico fin dalle prime pagine e diventa un compagno
inseparabile entro la fine del libro.
Gaiman è davvero abile a tratteggiare la
personalità del piccolo protagonista. Credo, e da quello che c’è scritto nei
ringraziamenti penso di non sbagliarmi, che l’autore abbia tratto molto dalla
propria infanzia e da quello che lui stesso era a quell’età per creare la
figura di Neil. Il risultato è un personaggio gradevole e non scontato (a parte
per qualche dettaglio), che cresce nel corso della storia. Gaiman fa attenzione
ad avere sempre presente che quello che parla è un bambino, e quest’idea
influenza anche il linguaggio, che ho trovato più semplice di quello di American gods. Quando saltano fuori dal
nulla parole inventate dobbiamo pensare che sia qualcosa di voluto dall’autore
per essere coerente con l’età del personaggio narrante.
Una delle cose che funzionava di meno in
American gods era la trama. O meglio,
se ricordate avevo sottolineato come una volta che si comprendeva il taglio che
Gaiman voleva dare alla narrazione allora tutto diventava chiaro, mentre fino a
quel momento si rischiava di non apprezzare certe derivazioni della storia e di
considerarle come delle inutili diramazioni. Bé, mi sono reso conto che il
punto focale della faccenda è che Gaiman si trova molto più a suo agio a
gestire un tipo di trama come quella de L’oceano
in fondo al sentiero. Qui ci sono pochi personaggi da gestire, ma
soprattutto non serve preparare nessun grande evento, o comunque gestire
differenti sottotrame. C’è soltanto lo sviluppo principale della vicenda, che
prosegue in modo lineare ma non per questo scontato o noioso. La bravura di
Gaiman emerge in questo modo in maniera molto evidente e incisiva.
 |
| L'atmosfera del romanzo. |
Insieme all’atmosfera fiabesca si
respira un forte senso di mistero che dà alla vicenda un grande fascino. Le
leggi del mondo con cui Neil viene a contatto, i poteri delle persone che
incontra, le creature che gli si parano contro, tutto questo non viene mai
spiegato in modo esplicito. Possiamo comprendere che delle regole esistono,
veniamo perfino a conoscenza di alcune di esse, ma il lettore viene informato
solo di quello che accade nella trama perché ad essa è funzionale. Tutto il
resto non viene mai rivelato. L’autore gestisce le cose in modo così magistrale
che chi legge non ha l’impressione che stia affastellando poteri a casaccio
come gli tsubo di Ken il guerriero, ma che esista tutta una serie di norme che
esistono e che i personaggi rispettano ma che il protagonista non conosce.
Questo effetto non solo desta moltissimo interesse verso i poteri e verso i
personaggi che li possiedono, ma evidenzia l’intelligenza di Gaiman e
l’accortezza con cui ha pensato il tutto.
L’atmosfera è in assoluto la cosa che
colpisce di più del romanzo, oltre a ciò che spinge a continuare la lettura e,
giunto verso la fine, mi faceva dispiacere l’idea che finisse. Fate conto che voltavo le pagine con l’ansia che quella che
stavo per leggere fosse l’ultima. Non è una cosa che mi succede spesso, non mi
è successa neppure con libri come It o
Pan. A memoria d’uomo mi è successo
solo con Joyland, che non è che sia
nulla di che, ma appunto è caratterizzato da un’atmosfera molto particolare.
Stiamo parlando di giusto giusto due anni fa. Non è cosa da poco.
Non mancano i cliché e le cose già
viste. Una su tutte la scena iniziale del compleanno di Neil, cui non partecipa
nessuno, e la torta con un libro di glassa sopra viene consumata dal ragazzino
insieme alla famiglia. È altrettanto cliché la scena che segue, in cui si
racconta della passione di Neil per la lettura. È un po’ cliché pure Ursula
Monkton, se proprio devo mettermi a spezzare il capello in quattro. Ma il punto
è che a conti fatti di questi cliché non frega niente a nessuno, non danno
fastidio. Il fiabesco, la delicatezza e la semplicità che caratterizzano storia
e narrazione rendono accettabili e piacevoli perfino questi elementi che in
qualunque altro contesto, o raccontate dalla penna di uno scrittore meno
esperto, avrebbero puzzato di vecchio e già visto.
Inutile dire che la narrazione scorre
che è un piacere, il primo giorno che l’ho letto (il secondo lo avevo già finito)
sono arrivato a pagina 100 senza praticamente accorgermene. Dovevo preparare un
seminario per l’università da presentare la lezione successiva, seminario che
avrebbe determinato metà del voto finale dell’esame quindi dovevo dedicargli
attenzione e voglia, e invece mi sono trovato a non riuscire a smettere di
leggere Gaiman.
Ho trovato anche la presenza dei gatti
nella trama un tocco veramente particolare e affascinante. Non perché abbiano
un ruolo specifico nella svolgersi delle vicende, anzi, potrebbero proprio non
esistere che non cambierebbe nulla. Ma, a parte che l’amore che il protagonista
prova per loro è talmente ben reso che solo quello giustificherebbe la loro
presenza, trovo che siano un ottimo modo per aumentare il fascino
dell’atmosfera. La presenza della gattina contribuisce a intensificare la
delicatezza e il mistero di cui ho parlato prima. Sembra un dettaglio, ma senza
i gatti il fiabesco che tanto mi ha colpito e ho apprezzato non sarebbe
risultato così efficace.
 |
| "Un 10! EVVAI!" |
IN CONCLUSIONE
Scrivere una recensione di un libro
stupendo è una grande soddisfazione. È meglio che scrivere recensioni negative,
le recensioni negative riportano brutti ricordi. Quelle molto positive il
contrario. Tuttavia, è anche molto difficile, ho sempre l’impressione di non
essere riuscito a mostrare del tutto quello che il libro mi ha trasmesso. Sto
avendo quest’impressione anche adesso. Potrei ripetere settecento volte che L’oceano in fondo al sentiero è
meraviglioso, bellissimo, un romanzo eccellente, ma non vi trasmetterei molto,
perché starei raccontando, e invece, come ci insegna qualcuno, bisogna
mostrare, non raccontare. Bé, l’unico modo per mostrare sarebbe riportarvi
direttamente il libro. Quindi in sostanza il mio dilemma di non riuscire a
trasmettere al meglio quanto mi è piaciuto questo romanzo è irrisolvibile,
perciò andiamo avanti.
Sul retro della mia edizione di American gods è riportata una citazione
di Stephen King a proposito di Gaiman. “Leggere Gaiman è come entrare in una
stanza del tesoro piena di storie meravigliose”. Dopo aver letto L’oceano in fondo al sentiero non posso
che essere d’accordo con lui. Se lo leggerete troverete mistero, avventura, un
po’ di fiabesco, dei personaggi molto ben caratterizzati e a cui è facilissimo
affezionarsi, e anche qualche riflessione sulla conoscenza e la vita. Quindi
leggetelo. Fidatevi. Io il mio di dargli 10 Cthulhu (se li merita tutti e anche
se non fosse così è da poco passato Natale e siamo tutti buoni anche se ancora
per poco) l’ho fatto. Ora sta a voi fare la vostra parte e leggerlo. Io sono
felice di non sapere tutto, quindi torno a giocare davanti al casale e al
cielo, all’impossibile luna piena e le matasse e gli scialli, gli sciami e gli
ammassi di stelle lucenti.
VOTO: